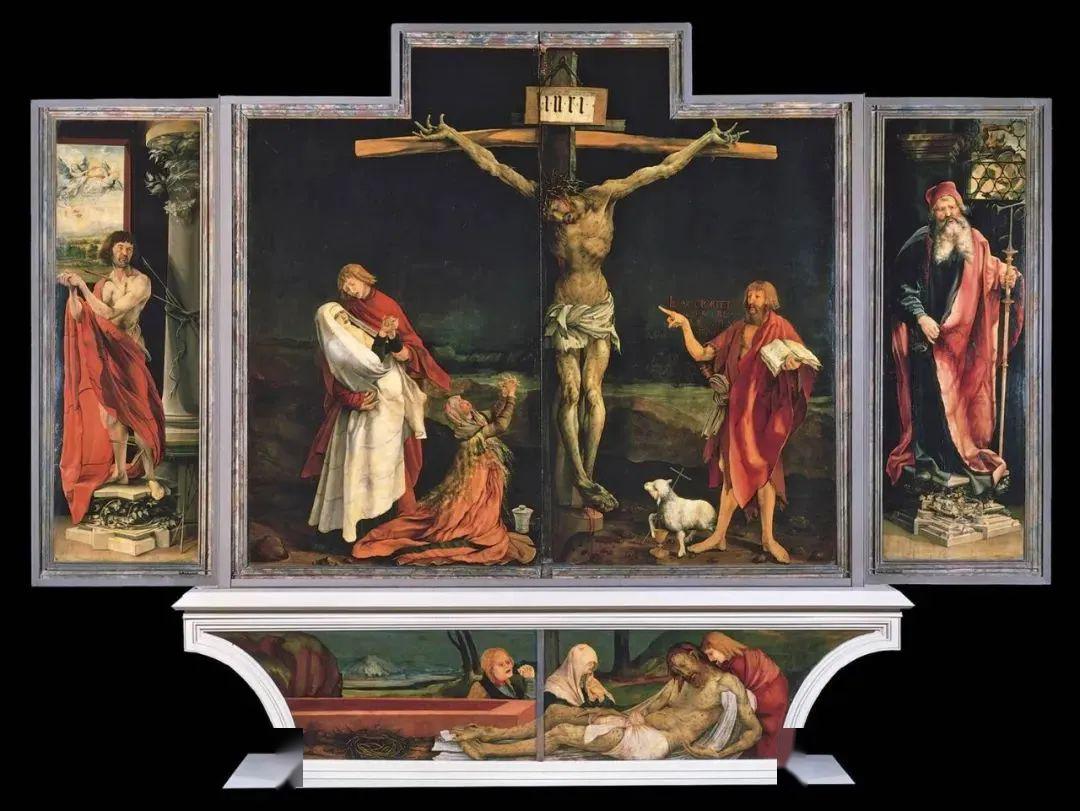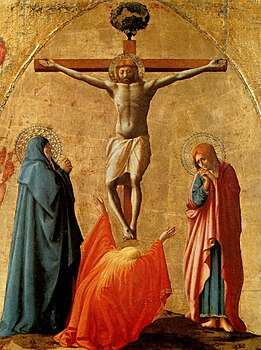Premessa, necessaria…
Vorrei scrivere alcuni post sul tema del capro espiatorio. Ad ogni post vorrei aggiungere la foto con la descrizione di un’opera d’arte pittorica. Tale thread va bene in questa sezione “arte e letteratura” oppure va collocato nella sezione “religioni e spiritualità” ?
L’argomento “capro espiatorio” coinvolge la storia religiosa, la teologia, ma anche la letteratura, densa di storia e narrazioni individuali, perciò questa discussione la lascerei “alloggiare” in questa sezione, se le beneamate moderatrici sono d’accordo.
Allora comincio con la “Celebratio passionis Dominis”: il venerdì che precede la Pasqua cristiana i fedeli commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo, fondamento per considerarlo “capro espiatorio”.
Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, “Flagellazione di Cristo”, 1608 circa, olio su tela, cm 286 x 213, Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli
Il contrasto fra luce e ombra caratterizza numerosi dipinti di Caravaggio. Anche in questo lo sfondo scuro domina la scena, centrata intorno alla colonna dove è poggiato il Nazareno. Il suo corpo è illuminato da un fascio di luce.
Gesù, nudo, tranne che per il bianco perizoma che gli cinge i fianchi, ha la corona di spine sul capo chinato in segno di accettazione della volontà di Dio.
Intorno a lui ci sono due dei suoi torturatori. Quello di sinistra tira i capelli a Gesù, quello di destra gli lega le mani dietro la schiena facendosi forza con la gamba.
Un terzo uomo è in primo piano in posizione chinata mentre prepara il flagello (strumento di tortura), vicino la gamba sinistra del Nazareno.
Particolare dell’aguzzino in primo piano
Indagini ai raggi X hanno consentito di vedere che la tela è formata da tre distinti pezzi di stoffa, due con le stesse dimensioni sono uniti all’altezza dell’ombelico di Cristo, un altro, largo 17 cm, è aggiunto sul margine destro per completare il piede dell'aguzzino, con la realizzazione del suo tallone, che in origine era tagliato.






 Rispondi Citando
Rispondi Citando